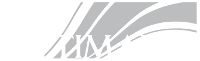Andrea Cozzo, docente di Lingua e letteratura greca presso l’Università degli Studi di Palermo, in cui ha tenuto, per gli studenti, laboratori di Teoria e pratica della non-violenza, è autore di diversi libri sia sul mondo greco antico che sull’azione non-violenta; ha recentemente pubblicato il volume Media di guerra e media di pace sulla guerra in Ucraina. Promemoria e istruzioni per il futuro, Mimesis 2025. L’intervista è a cura di Giordano Cavallari.
- Gentilissimo Andrea, quali sono i caratteri del “giornalismo di guerra” comuni a tutte le guerre?
Direi, in generale, quello del pensare per polarità: Buoni vs. Cattivi, Bene vs. Male… che, naturalmente, identifica ogni volta il primo membro dell’opposizione con il “Noi” o “I nostri” o, insomma, coloro con cui noi ci schieriamo; e il secondo con l’“altro”.
Su questo schema si innesta tutta la narrazione del conflitto armato che è di carattere puramente propagandistico: gli elementi della propaganda, rintracciati da sir Arthur Ponsonby (Falsehood in War Time: Containing an Assortment of Lies Circulated Throughout the Nations During the Great War) già nel 1928, dopo la Prima guerra mondiale, e da me richiamati nel volume – e, se posso permettermi, dal sottoscritto stesso (La logica della guerra nella Greci antica. Contenuti, forme, contraddizioni, 2024) – sono tutti presenti nella maggior parte dei media contemporanei, almeno dal febbraio 2022 ad oggi.
- Nel caso della guerra in Ucraina – al centro della sua analisi – quali caratteri, in particolare, lei ha individuato? Può fare qualche esempio?
Gli esempi possibili sono, purtroppo, numerosissimi. Li distribuirei in alcune categorie. Ecco le principali.
(1) Le fake news più spudorate: come quella dei 70 anni di pace in Europa prima dell’invasione russa dell’Ucraina, che “dimentica” le guerre del 1995 e del 1999 nell’ex Jugoslavia alle quali ha partecipato attivamente – e alla seconda anche illegalmente, visto che non c’era l’autorizzazione dell’ONU! – pure l’Italia; o quella secondo cui l’Ucraina non aveva mai avuto intenzione di entrare nella Nato, laddove tale intenzione è espressa persino in diversi articoli della Costituzione ucraina.
(2) Le omissioni: basti ricordare la quasi totale mancanza di informazione sull’opposizione del Movimento Nonviolento Ucraino (presieduto dall’obiettore di coscienza Yurii Sheliazhenko), sia all’invasione russa, sia alla resistenza armata (con annesso invito ai governi europei di non inviare armi bensì di spendere i loro sforzi nell’azione diplomatica); oppure, il trascurabile rilievo dato alla notizia della richiesta che Putin aveva fatto al segretario della Nato Stoltenberg – che l’aveva rifiutata già tre mesi prima dell’invasione – di non continuare ad espandersi se non voleva che l’Ucraina venisse attaccata; dare risalto a ciò avrebbe significato mostrare l’evidente corresponsabilità del “Noi” nell’attacco russo.
(3) Le derisioni, anche nel senso letterale del termine: si pensi alle risate di alcuni giornalisti presenti nello studio di DiMartedì il 3 maggio 2022, mentre parlava, in collegamento da Mosca, la russa Nadana Fridrikhson che era stata invitata alla trasmissione, oltre alle offese ai pacifisti, accusati da qualcuno di “idiozia sesquipedale”, da altri di “ipocrisia” (nel mio libro fornisco i precisi riferimenti).
(4) Gli articoli, che – mentre non davano nessuna informazione su quanto avveniva a Kiev – esibivano enfasi e lirismo, fatto di pathos e abbondanza di figure retoriche, finalizzati ad un “tifo” unilaterale e a una pretesa lezione di morale ai manifestanti per la pace il 5 novembre 2022.
(5) La dichiarazione – fondata su una citazione del tutto decontestualizzata –, che persino Gandhi si sarebbe schierato a favore dell’invio di armi all’Ucraina.
(6) L’incapacità di vedere come la firma di un documento di garanzia che l’Ucraina non sarebbe mai entrata nella Nato – da sempre la principale richiesta di Putin, già avanzata da molti analisti politici americani stessi fin dai primi anni Novanta, cioè da quando ormai il fronte “nemico” dei Paesi comunisti non esisteva più –, avrebbe evitato o, poi, interrotto il conflitto armato e la perdita di centinaia di migliaia di vite umane.
***
- Può spiegare l’effetto D–M–A di cui tratta nel libro?
D–M–A è la “formula” con cui Johan Galtung ha sintetizzato il meccanismo della violenza, in quanto fondata su Dicotomizzazione (ci sono solo due parti ognuna delle quali è omogenea al suo interno: “Noi” vs. “Loro”), Manicheismo (da una parte – la mia – sta tutto il Bene, dall’altra tutto il Male), Armageddon (la vittoria militare è l’unico scopo).
Tale formula è stata sponsorizzata dai nostri media (sia cartacei, sia televisivi, sia online), sostanzialmente con tre sole grandi eccezioni: Avvenire, Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto. Beninteso, si tratta di un sistema culturale diffuso – non del modo di pensare bellicista di singoli individui – ed è per questo che non ho mai inteso criminalizzare i giornalisti che lo hanno adottato – penso inconsapevolmente – nella maggior parte dei casi, tranne, naturalmente, quando si è trattato di vere e proprie e volute fake news.
Purtroppo, per correttezza di informazione, nel libro non ho potuto fare a meno di citare, di volta in volta, i loro nomi, visto che era doveroso scrivere chi fossero gli autori delle parole che analizzavo e criticavo.
- I social hanno amplificato e amplificano tale effetto?
Non ho molti dubbi sul fatto che i social, con la loro “scrittura breve” che, tendenzialmente, impedisce l’argomentazione strutturata e argomentata, abbiano acuito e acuiscano il sistema di pensiero D–M–A. Ciò avviene particolarmente nella posizione di chi è a favore dell’invio di armi all’Ucraina e della continuazione della guerra – subìta dagli Ucraini! – “fino alla vittoria”.
Mentre – come ho detto – si sarebbe potuto spingere per negoziati di pace che tenessero conto delle esigenze di entrambi i popoli, cioè sostanzialmente del loro bisogno di sicurezza, che poteva e potrebbe ancora essere soddisfatto da un accordo che preveda la garanzia di non-ingresso dell’Ucraina nella Nato attraverso la variazione dell’art. 5 della stessa Nato (per cui si possa dare un intervento armato a difesa dell’Ucraina solo nel caso che questa venisse di nuovo attaccata nonostante la sua rinuncia ad entrare nel Patto Atlantico).
Ci si sarebbe potuti spendere, soprattutto, per iniziative di rafforzamento della fiducia tra i popoli, sviluppo di legami economici e politici, scambi culturali.
***
- Anche lei, personalmente, si sente vittima dell’effetto e della violenza culturale conseguente?
Nonostante abbia cercato di prendere tutte le cautele possibili per non risultare ambiguo, anche a me è toccato di sentirmi apostrofare, su Facebook, come “putiniano”, non solo da “amici virtuali” ma anche da giornalisti professionisti, per il semplice fatto di essermi rifiutato di definire Putin – la cui azione ho sempre esplicitamente condannato – “il Male Assoluto”!
- Ritiene che papa Francesco si sia distinto in altro modo nella guerra mediatica dentro la guerra in Ucraina?
Certamente! Papa Francesco non ha esitato a mettere in luce le “nostre” corresponsabilità con la sua celebre sottolineatura dell’«abbaiare della Nato alle porte della Russia» quale fattore provocatorio determinante nell’invasione russa dell’Ucraina, e a dare un chiaro messaggio sulla via da seguire quando – per il Venerdì Santo del 2022 – ha chiesto (e ottenuto) che, a portare la Croce, fossero, insieme, una donna russa e una donna ucraina. È stato un esempio di logica della costruzione della pace, fondata sul rigetto del “tifo” per uno dei due popoli belligeranti, sulla non criminalizzazione di nessuno di loro, sulla vicinanza ad entrambi.
È stato un esempio per come il fulcro della costruzione della pace stia, per ogni parte in conflitto – e a maggior ragione per “noi”, parte terza –nella capacità di sentirsi compartecipi della sofferenza dell’altra parte e di cooperare, di stare in dialogo, aiutandosi vicendevolmente a sorreggere la croce delle relazioni umane mal impostate, mettendo da parte il male subìto o inflitto – i Greci antichi parlavano, appunto, di mé mnesikakéin, del “non ricordarsi del male” – per andare finalmente oltre l’odio e le armi, avviandosi verso la riconciliazione.
Penso che l’invito di Leone XIV a che le diocesi promuovano percorsi di educazione alla nonviolenza – che spero non vengano improvvisati ma siano frutto di conoscenza e di competenza – possa costituire un ulteriore sviluppo del pensiero della costruzione della pace di papa Francesco.
- Lei ritiene che sarebbe stata possibile un’azione non-violenta del popolo ucraino?
Penso che sia importante fare chiarezza su una questione: quella dei tempi dell’intervento nonviolento per lo più considerata in modo equivoco.
Siamo soliti tirare in ballo – e giudicare – la possibilità e l’efficacia dell’azione nonviolenta quando una guerra è già scoppiata, cioè nel momento dell’emergenza. Certamente, anche in questo caso la nonviolenza ha un ruolo da giocare.
Ad esempio: “dal basso”, attraverso pratiche di interposizione ad opera di terze parti costituite da civili disarmati, o di pura esposizione dei propri corpi inermi di decine di migliaia di civili dello stesso Paese invaso: ricordiamo la celebre foto del ragazzo cinese che, nel 1989, a piazza Tienanmen che costringe, “semplicemente” ponendoglisi davanti, un carro armato a fermarsi? Ebbene, coraggiosi tentativi di questo tipo sono stati attuati anche in Ucraina; allora pensiamo a quale effetto avrebbe potuto avere tale azione se fosse stata realizzata contemporaneamente da migliaia di persone; “dall’alto”, attraverso la diffusione delle ambasciate di Paesi stranieri in ogni città ucraina, perché potessero funzionare da scudi umani internazionali.
Sono solo due esempi delle tante forme di resistenza disarmate possibili. Ma il tempo dell’emergenza non è l’unico né il più adeguato a pensare l’azione non violenta, che va concepita quale risposta non solo improvvisata ma anche preparata attraverso u un’apposita formazione in tempi di pace.
D’altronde, neppure nella difesa armata nessuno si sogna di prescindere dal normale addestramento alla stessa quando ancora la guerra conclamata non c’è. Ben sappiamo che – perché in guerra le armi possano essere imbracciate e la disciplina militare possa essere attuata – bisogna esservi stati istruiti prima.
Dunque, la soluzione per il caso di eventuali invasioni è la formazione strutturale alla logica e alle tecniche della nonviolenza, che costituisce anche un vero e proprio campo di studi – a cui sono personalmente dedicato – di ambito sociologico; non basta, evidentemente, un semplice discorso di carattere edificante e moralistico, sul “dovere di essere buoni” (i cui contenuti concreti restino poi del tutto oscuri e privi delle necessarie conoscenze tecniche).
***
- Perché l’azione non-violenta – e la pace – stanno con la democrazia, mentre la guerra sta con la democratura, come lei spiega?
La democratura, cioè il regime formalmente democratico, ma di fatto autoritario fino all’esercizio della violenza all’interno e ostile all’esterno, è la degenerazione della democrazia che vi sfocia inevitabilmente, se non abbraccia per tempo la nonviolenza in tutti gli ambiti.
La degenerazione avviene in maniera lenta e inconsapevole, quando uno dei valori fondamentali, ma non l’unico della democrazia, ossia quello della libertà, finisce per diventare un assoluto, senza essere coniugato – sempre e insieme – con quello della giustizia (che a sua volta, se basata sul dialogo, non può che diventare equità) e soprattutto della fraternità, per dirla ricordando il trinomio ideale della Rivoluzione francese; ma potremmo, in prima istanza, accontentarci di una più realistica “solidarietà” al posto della “fratellanza”.
La “libertà”, in sé sola, è valore individuale che diventa presto individualistico, e porta al principio del «tutto ciò che non è vietato, è permesso», all’apologia dei “diritti” indipendenti dai “doveri”, alla scomparsa dell’etica e, sul piano economico, al liberismo basato sulla competizione più sfrenata: di fatto, dunque, al “diritto” del più ricco, del più potente, del più forte, individuo o Stato che sia.
Solo se facciamo camminare “libertà” insieme a “giustizia/equità” e “solidarietà”, in un orizzonte culturale, intellettivo ed emotivo, di empatia e di cura – non semplicemente di rispetto – e dunque di gestione nonviolenta delle differenze, avremo vere ed effettive democrazie di pace, cioè sempre maggiore eliminazione di oppressione diretta, strutturale e culturale, sia all’esterno sia all’interno dei loro territori.
- Quindi un altro “giornalismo” e un’altra cultura “di pace” sono possibili?
Schematicamente (rimandando al libro per i dettagli), il giornalismo di pace ha il compito di: smascherare le fake news; rivelare gli eccessi commessi e le sofferenze subìte da persone di ogni fazione; dare voce a tutte le parti coinvolte, non solo ai Governi ma anche alla gente comune, mostrando l’esistenza di varietà di posizioni anche all’interno di ogni “fronte”; stimolare tutte le parti a prospettare soluzioni creative e non armate per la risoluzione dei conflitti e il raggiungimento e il mantenimento della pace; dare spazio alle azioni nonviolente…
E, nel raccontare ciò che avviene, il giornalismo ha il compito di chiedersi se il modo in cui si sta raccontando induce chi legge a odiare qualcuno – aggressore o aggredito che sia – e a credere che l’unico modo di risolvere il conflitto sia quello bellico, oppure a odiare soltanto la violenza e quindi a cercare come raggiungere la pace per vie nonviolente: solo in quest’ultimo caso si sta facendo giornalismo di pace!
***
- Lei ci sta lavorando, specie con i giovani, suoi studenti?
Ci ho provato, e non solo con i miei studenti universitari – con loro ho tenuto, per otto anni, anche uno specifico Laboratorio di “Teoria e pratica della nonviolenza” – ma anche con quelli delle scuole, con i giovani di Centri sociali e con associazioni, e pure con le forze dell’ordine (Arma dei carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Vigili urbani) per le quali ho tenuto diversi corsi di “Gestione nonviolenta dei conflitti”.
Comunque, non sono certo da solo: negli ultimi anni insieme ad altri amici del Centro territoriale palermitano del Movimento Nonviolento di cui faccio parte e, da quest’anno, con la neonata Officina Siciliana di Nonviolenza che, con altri gruppi, abbiamo costituito su iniziativa di Enzo Sanfilippo (della “Comunità dell’Arca”), operiamo nell’ambito della formazione alla nonviolenza più organicamente e diffusamente.
E il fatto che buona parte dei governi del mondo – Governo italiano compreso – stia andando in direzione opposta, cioè nella direzione di un’ulteriore militarizzazione della cultura e del pensiero, ci spinge ad impegnarci con ancora maggiore e più gioiosa determinazione.